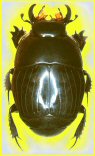Questo problema è apparso varie volte in varie discussioni, ma non è stato mai affrontato in maniera approfondita. Spesso sono stato proprio io a tirarlo in ballo, e malgrado svariati tentativi non sono ancora riuscito a porvi rimedio. Chissà che non ci si riesca con l'aiuto del Forum?
Intanto, che si intende con aberrazione cromatica?
Di fatto, si tratta di un effetto dovuto all'indice di rifrazione dei materiali usati per costruire le lenti di microscopi, telescopi, macchine fotografiche, ecc.
Consiste in questo: ogni materiale trasparente alla luce presenta un diverso indice di rifrazione. Qunado la luce passa da un mezzo ad un altro con indice di rifrazione diverso, subisce una deviazione, avvicinandosi o allontanandosi dalla perpendicolare al piano di separazione tra i due mezzi trasparenti. Questo fenomeno fisico è quello grazie al quale funzionano le lenti di ogni apparecchio ottico.
Il problema nasce dal fatto che le diverse frequenze luminose vengono deviate in misura diversa. Nella maggior parte dei casi non si nota, ma quando si ha a che fare con ingrandimenti molto spinti dell'immagine (tipicamente nei telescopi, ma anche nei microscopi e usando teleobiettivi di focale molto lunga), il risultato è che l'immagine si forma sfalsata nei fari colori. I colori fondamentali sono tre: rosso, verde e blu (con frequenza crescente), quindi per forti ingrandimenti, ad esempio, una linea nera, fornisce un'immagine ingrandita bordata da bande, più o meno sfumate, di questi colori.
Inserisco una semplice immagine (per comodità, presa da Wikipedia) di quello che avviene:
Per cercare di compensare questo effetto, sono state introdotte già da molto tempo le lenti acromatiche, che correggono lo spostamento dei due colori estremi, quelli che subiscono la maggiore e minore deviazione, il blu e il rosso, che creano normalmente i maggiori problemi.
Nella maggior parte dei casi questo risolve il problema, anche perchè l'aberrazione cromatica è evidente soprattutto sulla parte di immagine che si forma sui margini della lente, mentre quella formata dalla luce che attraversa la zona centrale ne risente molto meno.
Da qui nasce il problema con i binoculari.
Tipicamente, in un microscopio di questo tipo, le due vie ottiche ricevono la luce che passa attraverso un unico obiettivo di grandi dimensioni. Per cui, l'oculare destro riceve luce che passa nella metà destra dell'obiettivo, e l'oculare sinistro quella della metà sinistra. Ne consegue che viene sfruttata proprio la parte delle lenti dell'obiettivo in cui l'aberrazione cromatica è più accentuata! Normalmente non ce ne accorgiamo, perchè guardando nei due oculari contemporaneamente i nostri occhi ricevono due immagini corrispondenti, leggermente diverse come punto di vista, tanto da mantenere la percezione della tridimensionalità, in cui l'effetto della aberrazione cromatica è esattamente invertito e annullato dal cervello. In pratica, ecco cosa vedrebbe ogni nostro occhio se non intervenisse il cervello:
In queste foto di un piccolo Carabidae, fatte attraverso un Leica MZ6 al massimo ingrandimento e una Nikon Coolpix 4500 fissata prima su un tubo portaoculare e poi sull'altro, si vede cio' che vedrebbero i nostri occhi nei due oculari, destro e sinistro.
Potete notare che il rosso e il blu non danno problemi (obiettivo acromatico), ma il verde si sposta. In pratica c'è troppo verde verso l'interno dell'immagine (ovvero verso il centro dell'obiettivo) e troppo poco verso l'esterno (dove si forma una banda del colore complementare, ovvero il cosiddetto magenta). [Notare soprattutto ai lati del capo].
Osservando direttamente qualcosa col binoculare non ce ne accorgiamo, perchè le bande invertite di colori complementari vengono annullate dalla sovrapposizione delle immagini operata dal nostro cervello, ma quando fotografiamo usiamo una sola via ottica! Quindi restano le bande ben visibili.
Un sistema per risolvere il problema ci sarebbe, ovvero usare un obiettico apocromatico (o planapocromatico), che corregge anche la banda del verde. Ma si tratta di obiettivi molto costosi, con lenti in fluorite (che ha un indice di rifrazione diverso da quello dei vari vetri e plastiche) e che non si trovano per tutti i microscopi.
Un certo miglioramento si potrebbe avere chiudendo il diaframma, in modo da usare solo la luce che passa nella parte centrale dell'obiettivo, ma questo si può fare con un obiettivo fotografico, non certo con un binoculare (che il diaframma non ce l'ha, salvo alcuni che lo prevedono come accessorio, e che comunque agisce solo dopo, sulle due vie ottiche che portano agli oculari, non sull'obiettivo).
Ora vi chiedo: qualcuno di voi conosce un sistema o un espediente per ridurre l'entità di queste bande colorate? Io mi sono scervellato per mesi senza venirne a capo. Ho anche provato alcuni plug-in per programmi di fotoritocco, con risultati meno che scarsi.